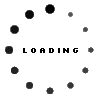“Stà lontan dai foss!”: la nonna mi ripeteva spesso di stare lontano dai fossi. Nella civiltà contadina si avvertiva un ancestrale timore nei confronti di certe infide acque, popolate, secondo i racconti di girovaghi, erranti e cantastorie, da strane e pericolose creature. Tale paura convinceva gli adulti ad ammonire i bambini del pericolo che si correva ad avvicinarsi alle rive di fossi, canali e pozze. In merito al timor panico delle acque si leggano le pagine scritte dal dialettologo parmense Giovanni Petrolini nel suo bellissimo libro Nel nocciolo delle parole. Stravaganze di un dialettologo, Parma, Edizioni Zara 1993.
Negli sterminati elenchi di mostri acquatici (con sicuro diletto si può consultare, di Alfredo Cattabiani, Acquario. Simboli, miti, credenze e curiosità sugli esseri delle acque: dalle conchiglie alle sirene, dai delfini ai coccodrilli, dagli dèi agli animali fantastici, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2002) manca il “motro” di Lunigiana. Motro: solo il nome mette paura. Basta la crasi di una ‘esse’ ed è fatta; da ‘mostro’ a ‘motro’ il passo è breve. (La mia amica Lucia, già lettrice di questa storiella, mi suggerì che pure l’anagramma da ‘motro’ a ‘morto’ è spaventevole assai).
Leggenda vuole che il motro appaia più frequentemente vicino ad un “bozzo” (bacino lacustre di piccole o medie dimensioni, “fondón”, come si dice in dialetto parmigiano) con l’aspetto di un minuscolo, ma terribile drago dalle squame color verde brillante.
Un vecchio boscaiolo di Montereggio (comune di Mulazzo, provincia di Massa Carrara) mi rivelò di aver avvistato un motro lungo le rive del Mangiola. Assieme a mio cognato decisi di risalire il torrente fino ad una cascata immersa nella fitta vegetazione di acacie. Il salto d’acqua terminava in un bozzo chiuso da una vasta formazione rocciosa scavata nel tempo dal flusso idrico. Il “bozzo” – sorprende l’affinità linguistica con “pozzo” – mi parve in effetti una sorta di pozzo; un pozzo talmente profondo che, immergendo lunghi rami legati alle estremità, non riuscimmo a trovarne il fondo. Probabilmente il fondale doveva essere molto scuro, così scuro da conferire all’acqua un colore nerastro. E nefasto – mi venne da pensare. Avrei voluto comunque tuffarmi in quelle acque tenebrose, ma un vago timore m’assalì. Riaffiorava l’antica ammonizione della nonna. Ancora immerso nel ricordo, fui richiamato dalle grida di mio cognato: – Guarda laggiù… ecco il motro! Mi girai e vidi (o meglio, credetti di vedere) un piccolo drago verde. Ma già ridevo del mio iniziale spavento: – Di’t dabón? Guerda bén, lé un ringolón! (Dici davvero? Guarda bene, è un… ramarro).
Pare che i romani, incapaci di catturare i liguri che scappavano e si nascondevano sulle montagne come fossero ramarri, scelsero di chiamarli “ligues”, dal nome delle grosse lucertole verdi dette ramarri, per l’appunto. Da “ligues” a “Liguri”. Ma questa è un’altra storia, oltretutto infida. Perché le incerte scorribande di etimologia sono infide. Come certe acque.
Luigi Lanzi
foto da L’ordinario, ph. Daniela Tresconi